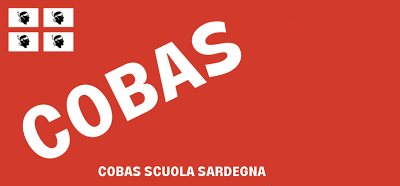intervista ad Andrea Scano: maestro elementare e pedagogista, attivista dei COBAS SCUOLA SARDEGNA di Stefano Bertoldi SCUOLA RESISTENTE Radio Onda d’Urto
intervista ad Andrea Scano: maestro elementare e pedagogista, attivista dei COBAS SCUOLA SARDEGNA di Stefano Bertoldi SCUOLA RESISTENTE Radio Onda d’Urto Registro elettronico come “errore pedagogico” e i rischi di...